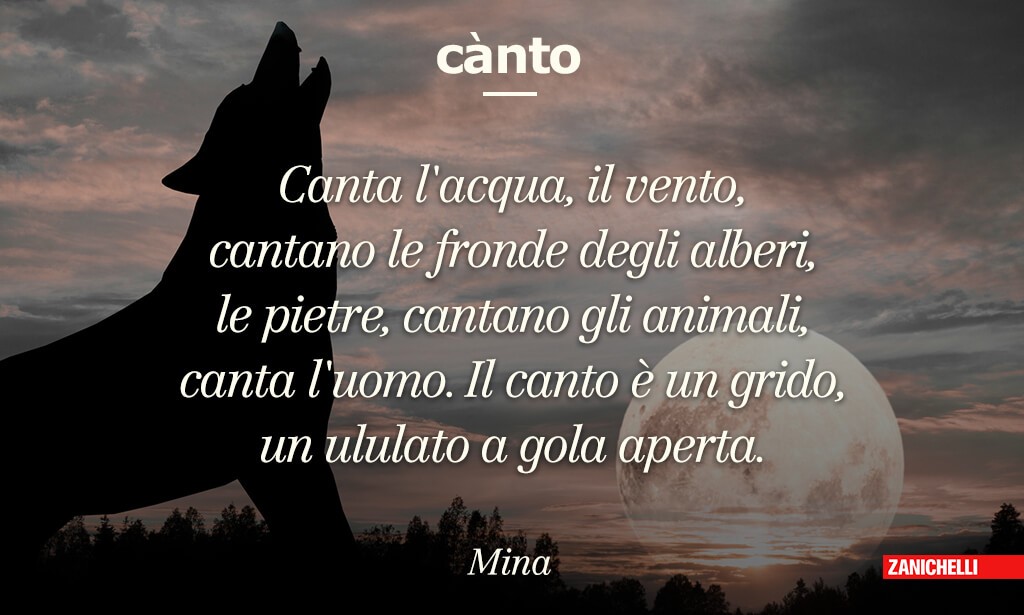 Definizioni d'autore
Definizioni d'autore
Canto
di Mina
"Dio non canta. Forse non ha mai cantato: si vede che non gli serviva..."

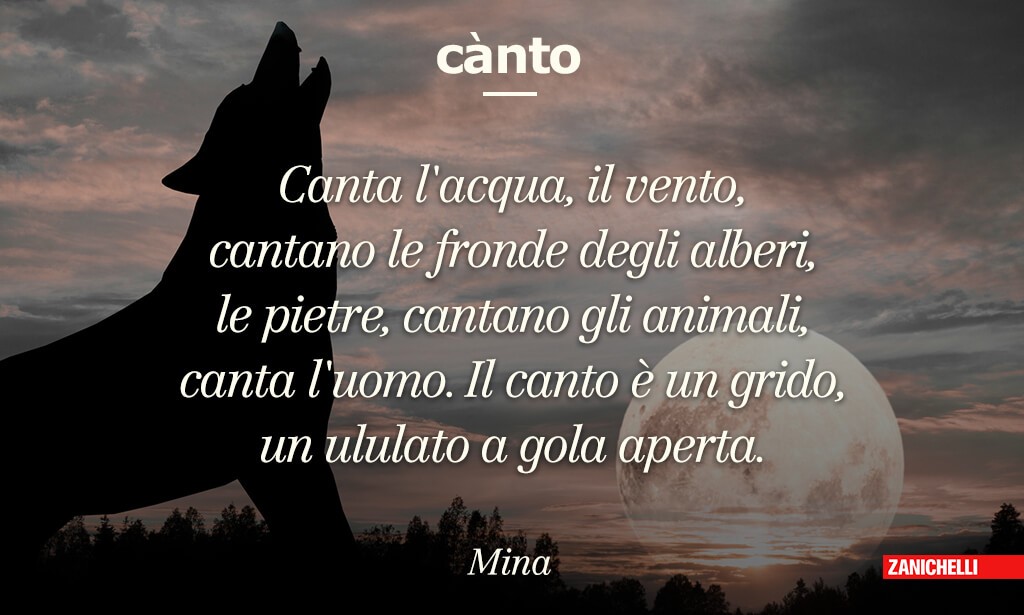 Definizioni d'autore
Definizioni d'autore
"Dio non canta. Forse non ha mai cantato: si vede che non gli serviva..."
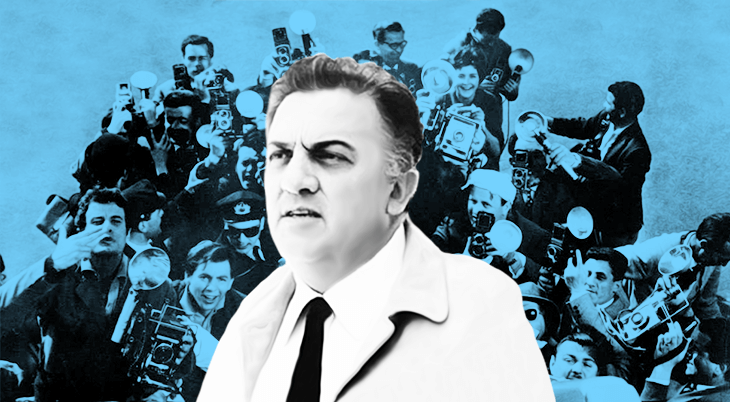 Parola di...
Parola di...
Un termine utilizzato per descrivere i fotoreporter a caccia di scoop, che spesso suona quasi dispregiativo, è paparàzzo. Entrato a […]
 Wordwatch
Wordwatch
Sesso e identità di genere possono, ma non devono necessariamente, coincidere. È solo di recente che si è cominciato a capire e accettare che il genere non è binario e che esistono moltissime identità di genere
 Il Film del Giorno
Il Film del Giorno
Nell'aprile del 1945, un manipolo di sopravvissuti al deserto africano e alle sabbie della Normandia.
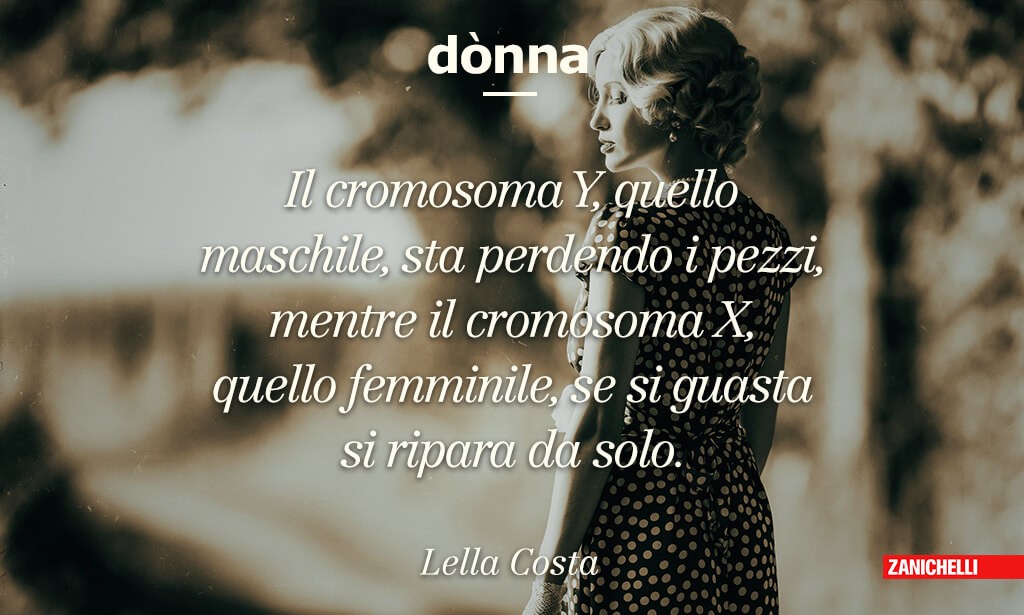 Definizioni d'autore
Definizioni d'autore
"Vanta un'etimologia assai nobile e promettente (domina, nientemeno) totalmente mistificata e tradita nel corso dei secoli." Scopri la #definizionedautore di Lella Costa.
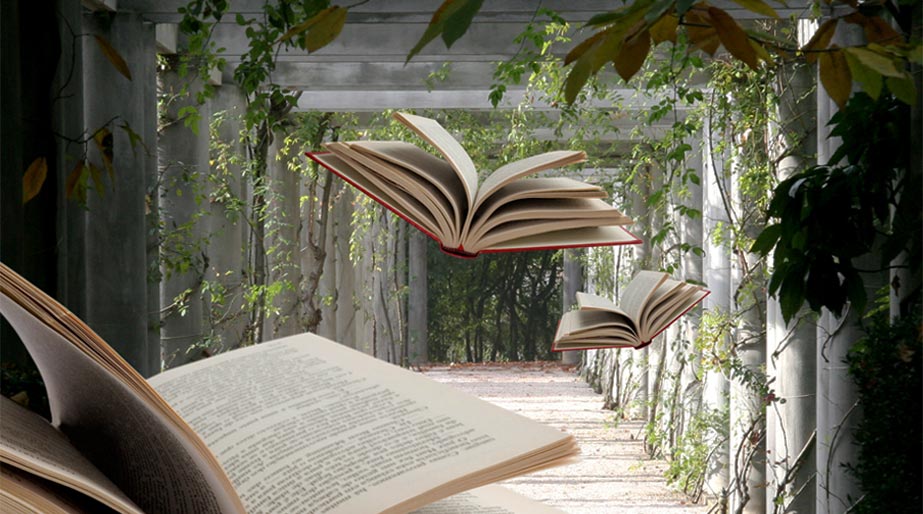 La parola del giorno
La parola del giorno
La parola di oggi è: trasmettitore / ricevitore La Parola del giorno ricorda Guglielmo Marconi. Continua il viaggio della Parola […]
Ogni giorno ti raccontiamo il mondo con parole, ispirazioni, definizioni, uno spunto in più per interpretare l’attualità e la cultura. Ti guideremo in un percorso fatto di linguaggi differenti, per darti gli strumenti più adatti a descrivere la realtà.
