Parole che bruciano: il racconto delle ingiustizie e delle proteste
a cura di Vera Gheno
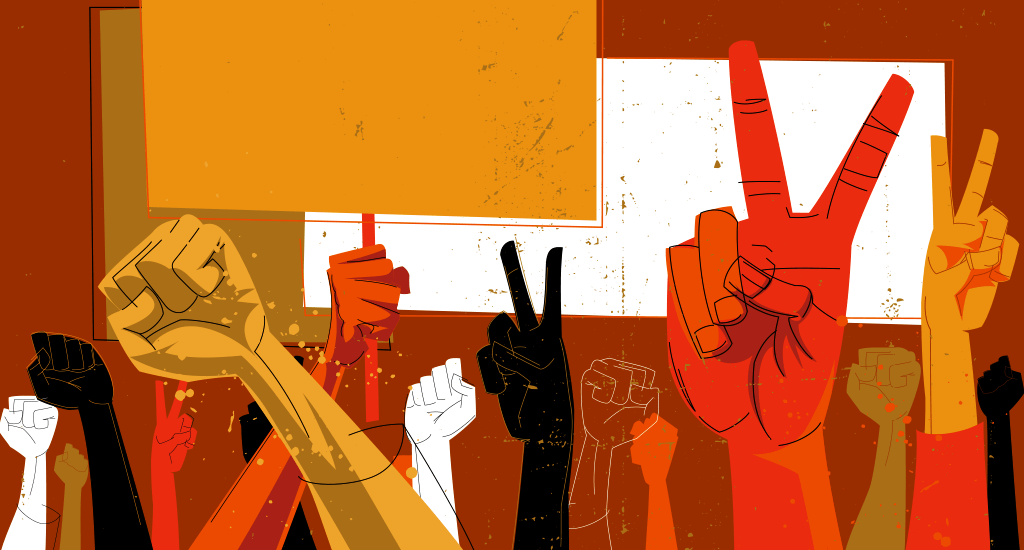
Abbiamo parole per fingere,
Parole per ferire,
Parole per fare il solletico.
[…]
Abbiamo parole per piangere,
Parole per tacere,
Parole per fare rumore.
Ecco due “terzine” della filastrocca Le parole di Gianni Rodari, messa in musica da Sergio Endrigo e Luis Bacalov negli anni Settanta. Ho pensato di aprire così questo glossario dedicato alle parole che feriscono e a quelle che fanno rumore; il tutto, ricordando le proteste, le rivendicazioni e le manifestazioni seguite all’inumano omicidio di George Floyd avvenuto il 25 maggio a Minneapolis. Per l’ennesima volta, purtroppo, è stato ribadito con dolorosa chiarezza che siamo ben lontani dal debellare le pulsioni umane più brutali. L’evoluzionista Telmo Pievani lo ricorda spesso, nelle sue conferenze: dobbiamo fare i conti con uno degli istinti naturalmente presenti nell’essere umano, ossia la xenofobìa. Dal greco xénos ‘estraneo, straniero’ e fobìa ‘paura’, indica genericamente un timore istintivo che proviamo nei confronti di tutto ciò che non conosciamo, che ci è ignoto, che appare “altro da noi”; tuttavia, continua Pievani, questa reazione istintiva dura più o meno un terzo di secondo: dopodiché subentra, o dovrebbe subentrare, la parte migliore di noi, ossia il ragionamento, il buon senso, l’intelligenza. Se c’è un modo per vincere, dunque, la xenofobia, è attraverso l’acculturamento, la conoscenza, che di fatto contribuisce a plasmare fisicamente il nostro cervello.
Una delle manifestazioni più orrende della xenofobia è proprio il razzìsmo (pronuncia corretta: /rattsìsmo/, dal francese racisme, da race ‘razza’, 1932), “ideologia che, in base a un’arbitraria gerarchia tra le popolazioni umane, attribuisce superiori qualità biologiche e culturali a una razza, affermando le necessità di conservarla pura e legittimando discriminazioni e persecuzioni nei confronti delle altre razze considerate inferiori” e, per estensione, “atteggiamento di disprezzo e intolleranza verso determinati individui o gruppi, basato su pregiudizi sociali radicati”. La parola ràzza (/ràttsa/, dall’antico francese haraz ‘allevamento di cavalli’, di etimologia incerta, av. 1388) è già di per sé, ultimamente, assai contestata: sono anni, peraltro, che si discute della sua eventuale rimozione dall’incipit dell’art. 3 della Costituzione italiana («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»). Ma sull’eventualità di toccare un testo estremamente riflettuto (i Padri della Costituzione sapevano cosa stavano facendo), specchio di un contesto storico specifico, molti autorevoli studiosi hanno manifestato perplessità, soprattutto perché è sempre rischioso imporre dei cambiamenti linguistici “dall’alto”, dato che è di fatto l’uso dei parlanti a modificare il linguaggio. Lo spiega reiteratamente nei suoi saggi uno specialista di linguaggi d’odio, il linguista Federico Faloppa, che recentemente ha ribadito, in un suo intervento su Facebook: «buttare la razza fuori dalla porta attraverso un’operazione nominale potrebbe essere poco produttivo se poi la si fa rientrare dalla finestra come categoria culturale il cui impatto opera anche in assenza del termine. Anche in questo caso, forse, contestualizzare criticamente è meglio che rimuovere».
Il termine razzismo si porta dietro automaticamente, nei nostri pensieri, un’altra parola: discriminazióne (dal latino discriminatiōne(m), da discriminātus ‘discriminato’, 1765), che di per sé significa, come il vocabolario ci insegna, ‘distinzione’, ma che viene usata soprattutto per indicare disparità di trattamento – e il suo impiego è più diffuso con questo significato meno neutro. Si discrimina, per l’appunto, chi è (sentito come) diverso; e questo porta spesso ad abùsi di potere. Abuso è un’altra parola dalla semantica complessa: dal latino abūsu(m), da abūti ‘adoperare, dilapidare’, da ūti ‘usare’, 1336 circa, significa “uso cattivo, illecito, eccessivo di qualcosa”; nella lingua del diritto è “esercizio di un diritto in contrasto con lo scopo per il quale è stato attribuito” e per estensione indica “violenza sessuale”.
Alla fine, rimaniamo sempre nella sfera della violènza, parola che a sua volta ha un’origine interessante, dato che deriva dal latino vīs ‘forza’, e che significa “caratteristica di chi (o di ciò che) è violento”. Abbiamo, in questi giorni, parlato spesso di violenze, al plurale, nel senso delle “azioni violente” messe in atto per protestàre contro un altro tipo di violenza davvero inaccettabile, quella a sfondo razzista. Del resto, ci sono momenti in cui, dopo che le parole sono state usate per ferire, come ci ricorda Rodari, è anche giusto usarle per fare rumore. E la protesta rientra sicuramente negli atti rumorosi, che valgono come testimonianza. Non a caso, il verbo protestare viene dal latino tardo protestāri, che significa proprio “testimoniare, attestare, dichiarare pubblicamente”. Dunque, si protesta per dichiarare pubblicamente, e urlando, la propria idea, la propria posizione.
La protesta ha varie sfumature. A parte il termine generico manifestazióne, la forma più comune e pacifica è forse quella del cortèo (dal provenzale cortejar, da cort ‘corte’, sec. XIII), “séguito di persone che accompagna qualcuno per rendergli onore, ossequio e simili” e “gruppo di persone che sfilano incolonnate nel corso di una dimostrazione pubblica”. Oltre che sfilare, le persone che compongono il corteo solitamente scandiscono degli slògan (dallo scozzese sluagh-ghairm ‘grido (ghairm) di guerra (sluagh)’, 1930), “breve frase che esprime in modo sintetico ed efficace un concetto, usato nella propaganda e nella pubblicità”. Di questi tempi, un modo tipico di far girare gli slogan è di trasmetterli sotto forma di hashtag: quello più comune in queste settimane è stato #blacklivesmatter, “le vite nere [o dei neri] valgono”, anche nella forma #BLM.

Ma quando il corteo non basta più, si ricorre a forme di protesta più estreme e anche più violente. Gli anglofoni parlano di riot, termine che prima di arrivare in inglese fa un giro etimologico complesso: deriva infatti dall’antico francese riote, ‘disputa’, probabilmente dal latino rugīre (come ormai ben sappiamo, degli etimi non sempre v’è certezza). Il termine riot, in italiano, viene tradotto principalmente come rivòlta. Ma non è l’unico termine che si può usare per indicare questo genere di avvenimenti. Abbiamo, sullo Zingarelli, una scheda di sfumature che mette in fila i termini ribellione – sollevazione – rivolta – sommossa – insurrezione e spiega:
«Ribellióne è la protesta di chi rifiuta di ubbidire o di sottomettersi a un’autorità, in famiglia come a scuola o nel lavoro; in senso più largo è la sollevazióne, specialmente in armi, contro un’autorità costituita. In questo secondo significato è prossimo a rivòlta, che è una ribellione a cui seguono tumulti. Una protesta popolare molto ampia accompagnata anche questa da scontri e tumulti si definisce invece sommòssa. Se la rivolta è fatta in armi, riguarda l’intera popolazione e ha come fine il rovesciamento del potere dello stato si ha un’insurrezióne.»
Per finire, vediamo l’origine di queste ultime parole: ribellione viene dal latino rebĕllis ‘ribelle’ (1312); sollevazione dal latino sublevatiōne(m) ‘alleggerimento’, da sublevātus ‘sollevato’ (sec. XIV); rivolta da ri-voltare, a sua volta dal latino parlato *volutāre, intensivo di vŏlvere ‘volgere’ (1266); sommossa dal latino submovēre ‘allontanare’, composto di sŭb ‘sotto’ e movēre ‘muovere’ (av. 1276); insurrezione dal latino tardo insurrectiōne(m), da insurrĕctus, participio passato di insŭrgere ‘insorgere’ (1570).

Dopo tutti questi tumùlti (dal latino tumēre ‘essere gonfio,’ e, figurativamente, ‘agitato, sovreccitato,’ di etimologia incerta, 1266), sento il bisogno di concludere con alcuni altri versi di Rodari, tratti da un’altra sua bella filastrocca, intitolata questa volta Parole nuove, che parla di un signore che inventa parole; in particolare, ne sta usando una che ci possa far diventare tutti un po’ più umani:
Io conosco un signore
che inventa parole nuove.
[…]
Ora ha in mente di inventare
il verbo “slitigare”,
per dividere i tipi letichini
e trasformare i nemici
in buoni vicini.
Finora quel verbo
gli è venuto maluccio, non funziona.
Ma lui non si sgomenta,
ogni giorno ritenta
e prima o poi di certo troverà
la parola per mettere d’accordo
tutta l’umanità.


